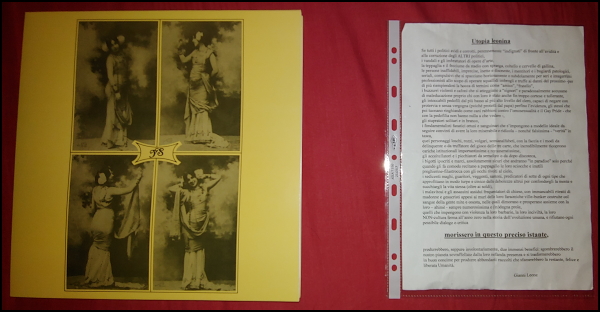Un po’ di tempo fa mi sono imbarcato nella lunga e impegnativa lettura de “Il crollo della mente bicamerale e l’origine della coscienza”, ma alla fine sono stato ripagato dalle forte suggestione che porta con sé l’impianto speculativo di Julian Jaynes. Non posso rendere giustizia a oltre cinquecento pagine piuttosto dense e quindi mi limito a farne una modestissima cernita, del tutto arbitraria e lacunosa, ma a mio esclusivo uso e consumo.
La premessa risiede nella considerazione della coscienza quale tardo prodotto del genere umano in virtù di una sua assenza negli aspetti culturali della specie fino a qualche millennio fa. Gli argomenti di questo primo sostegno mi convincono perché si stagliano sull’adozione della scrittura, momento nel quale s’indebolisce la tradizione orale e si avvia il progressivo esautoramento delle voci allucinatorie, ossia quell’autorità primeva che Jaynes attribuisce alla cosiddetta mente bicamerale e di cui, nella seconda metà del libro, suggerisce di ricercare le vestigia nella moderna schizofrenia che egli reputa un fenomeno residuale di quella forma mentis. A tale proposito reputo interessanti le correlazioni neurologiche a cui Jaynes si risolve per non limitare l’ipotesi a un quadro prettamente storico o etologico, perciò ne consegue un certo interesse per l’emisfero destro e per come quest’ultimo, nella mente bicamerale e nei casi di schizofrenia, sopravanzi nelle esternazioni quello sinistro che di norma è deputato al linguaggio.
I tentativi di definire la coscienza sono altrettanto ragguardevoli e nella prime pagine sono messi in rilievo con quella che a me ricorda la tecnica per via di levare di michelangiolesca memoria: la coscienza non è il deposito di concetti e di norma neanche se ne serve, non è necessaria all’apprendimento e talora può persino ostacolarlo, non serve alla ragione ancorché talvolta le due siano sovrapposte o considerate un tutt’uno; in ragione di tali punti è lecito supporre che sia esistita una razza di uomini la cui esistenza prescindeva dalla coscienza.
Secondo Jaynes ai tempi della mente bicamerale non esistevano incertezze e di conseguenza non sussistevano i presupposti per fenomeni come la preghiera; le teocrazie di cui fungeva da stampo erano soggette a una periodicità intrinseca di ascesa, caduta e ritorno, essa inoltre verteva sull’udito più che sulla vista (con la sollecitazione delle relative aree corticali), quindi l’avvento della scrittura confinò la parola del dio in una forma controllabile e le sottrasse il potere ubiquitario che imponeva un’obbedienza immediata dovuta alle allucinazioni uditive, le cosiddette “voci” tipiche anche della schizofrenia. In ultima analisi Jaynes interpreta (in termini generali, come egli precisa) la nascita della coscienza come il passaggio da una mente uditiva a una mente visiva.
Nonostante si tratti d’un testo un po’ datato (risale alla metà degli anni settanta) mi sorprende come prenda in considerazione una questione che da alcuni anni a questa parte avvince un certo pubblico (con Sitchin in primis e Biglino in seconda battuta), ossia quella degli elohim (termine ebraico sul quale sono stati versati fiumi d’inchiostro) a cui la teoria della mente bicamerale accorda il ruolo di visioni e voci, quindi risulta de tutto aliena (l’ironia è voluta) dalle ipotesi dei cosiddetti antichi astronauti o da qualsivoglia connotazione extraterrestre; corollario di tutto ciò è la maniera in cui Jaynes si approccia all’Antico Testamento nel quale egli vede essenzialmente un documento della perdita della mente bicamerale.
Un altro punto d’interesse per me è costituito dai connotati che la coscienza assume in tale contesto: essa spazializza il tempo trasformando la diacronia in sincronia e induce a vedere gli accadimenti in una giustapposizione spaziale. Ha qualcosa di potenzialmente copernicano quanto scaturisce da una tale prospettiva perché in essa, ad esempio, il senso della giustizia dipende dal senso del tempo e dalla successione spaziale così com’è posta in essere dalla coscienza.
Gli spunti sono innumerevoli e innumerevoli sono i passaggi da appuntare, difatti sulla mia copia grava il peso di molti adesivi e abbondano le parentesi quadre di cui la mia matita è prodiga, ma altrettanto copiosi sono i possibili sviluppi e le conseguenze da trarre.
Mi chiedo se Jaynes ammetta la possibilità di un’essenza metafisica nell’essere umano o se la sua concezione della coscienza costituisca per lui una pietra tombale su qualunque idea di questo genere, nondimeno parti delle sue tesi mi sembrano plausibili, in particolare quella sullo sviluppo del senso del sacro, altre invece le recepisco tanto avvincenti quanto azzardate.
Non già la coscienza in quanto tale, ma il suo concetto è un qualcosa di cui i possessori possono essere molto gelosi poiché definisce la loro individualità, di conseguenza mi domando se la lettura di un testo simile non possa essere inficiata da un cotale pregiudizio il quale, com’è possibile e probabile, rischia di aggiungersi alle eventuali inattendibilità e fallacie di certe supposizioni ivi presenti.